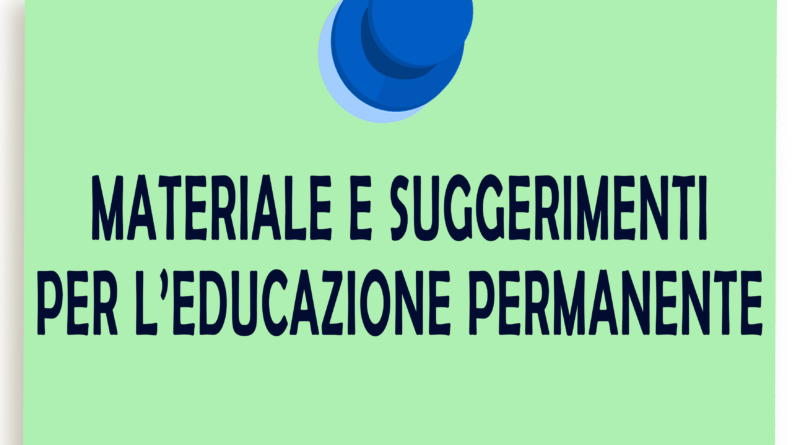Dopo il lockdown, tutto come prima? – Luigi Cioffi – CN- Triggiano (Puglia)
In estrema sintesi, la domanda che si è prepotentemente insinuata nei nostri pensieri è: domani, quando le restrizioni imposte dalla pandemia saranno terminate, tornerà tutto esattamente come prima?
Non è facile rispondere a questa domanda perché la “crisi” provocata dal coronavirus ha portato al pettine i tanti nodi irrisolti del sistema politico, sociale ed economico, che si è andato consolidando progressivamente nel “nostro” mondo occidentale.
Sono venuti al pettine i nodi istituzionali: il rapporto tra Stato centrale e autonomie locali, il rapporto tra Parlamento e Governo, il rapporto tra democrazia rappresentativa e stabilità di governo, il rapporto tra magistratura e politica; solo per citarne qualcuno.
Sono venuti al pettine i nodi di una Europa che fa fatica ad esprimere una propria identità, schiacciata come è dagli “egoismi” nazionali che, sempre più, si mostrano per quello che effettivamente sono: ricerca e consolidamento della legittimazione “popolare” al potere nazionale.
Sono venuti al pettine i nodi di una economia che “uccide” (per utilizzare le parole di papa Francesco). Un’economia fondata sul profitto (individuale) e non sul benessere (sociale). Un’economia che favorisce l’arricchimento di pochi a danno di molti, che si affida alla presunta capacità autoregolatrice del mercato, che considera il lavoro al pari degli altri fattori produttivi, che privilegia la rendita e delocalizza la produzione, e che di conseguenza produce “scarti”, che poi affida alla solidarietà di enti e associazioni benefiche. E infine, ma non per importanza, un’economia che consuma le risorse naturali senza minimamente pensare al futuro, accecata, com’è, dalla immediata massimizzazione del profitto.
Sono venuti al pettine i nodi di una classe dirigente mediocre o miope, appiattita sulla gestione dell’esistente, incapace di lungimiranza, di attivare processi di miglioramento continuo, di essere generativa, priva del coraggio necessario a contrastare quelle tendenze di cultura politica che interpretano l’organizzazione della società nell’esclusiva chiave di lettura di tipo economico. Un esempio per tutti: l’aziendalizzazione della sanità pubblica, ma anche della pubblica istruzione.
Sono venuti al pettine i nodi di una cultura sociale fondata sull’individuo, sulla sua assoluta libertà, che tutto giustifica e tutto rende lecito perché risponde al supremo diritto individuale di trovare risposte ai propri bisogni, trasformati in veri e propri diritti soggettivi, a scapito di una visione di benessere collettivo.
La visione unitaria di un Paese è stata trasformata in nazionalismo, il popolo in gente, le persone in categorie e la coesione sociale è stata trasformata in una mera contrapposizione di interessi che, alla fine, scontenta tutti proprio perché manca di una visione unitaria. Una cultura priva di morale e di etica che invita, di fatto, all’individualismo e all’egoismo.
Sono venuti al pettine i nodi di una Chiesa “clericale” che al Popolo di Dio in cammino, preferisce i praticanti le liturgie e i riti. Una Chiesa che appare invecchiata, irrigidita nella sua struttura, incapace di stare al passo con un mondo diventato plurale e veloce. Una Chiesa che parla un linguaggio incomprensibile, nonostante gli sforzi di papa Francesco che appare sempre più isolato.
È un breve elenco dei tanti nodi che la pandemia ha portato al pettine, e che -alla domanda iniziale- mi porta a rispondere: temo di sì, spero di no, dipende dalla capacità e volontà di ciascuno di voler essere protagonista (nel piccolo del proprio vissuto) della “ricostruzione”.
Il Masci può essere (secondo me, deve essere) soggetto attivo in questa fase di ripartenza, sia perché si richiama ai valori dello scautismo, sia perché si dichiara appartenente alla Chiesa.
Lo scautismo ci impegna a lasciare il mondo (un po’) migliore di com’è; Gesù, con il discorso della montagna, ci chiama all’impegno attivo per la pace e la giustizia.
Il Masci non può chiamarsi fuori dall’affrontare il tema dell’organizzazione della società e della chiesa; non può pensarsi esclusivamente dentro un percorso di educazione permanente che non sia fortemente ancorato quantomeno alla sola conoscenza critica delle strutture sociali ed economiche poste a base della società. Non può nemmeno pensarsi dentro un impegno di servizio (o di volontariato) che non si ponga domande sulle cause che provocano emarginazione sociale ed economica (vecchie e nuove povertà).
Per concludere: non credo sia necessario porsi nuove domande, quanto cercare nuove risposte a vecchie domande. Per esempio:
-che significa servire Dio? E il mio Paese? E gli altri? (dalla Promessa)
-chi è il buon cittadino?
-che significa lasciare il mondo un po’ migliore?
-cos’è il servizio?
-come si incarna l’educazione permanente per non farne solo un’esperienza “astratta”?
-la pastorale di papa Francesco incentrata sulla misericordia, sulla dignità della persona, e sul servizio agli ultimi, può diventare la cifra della nostra spiritualità?
Luigi Cioffi